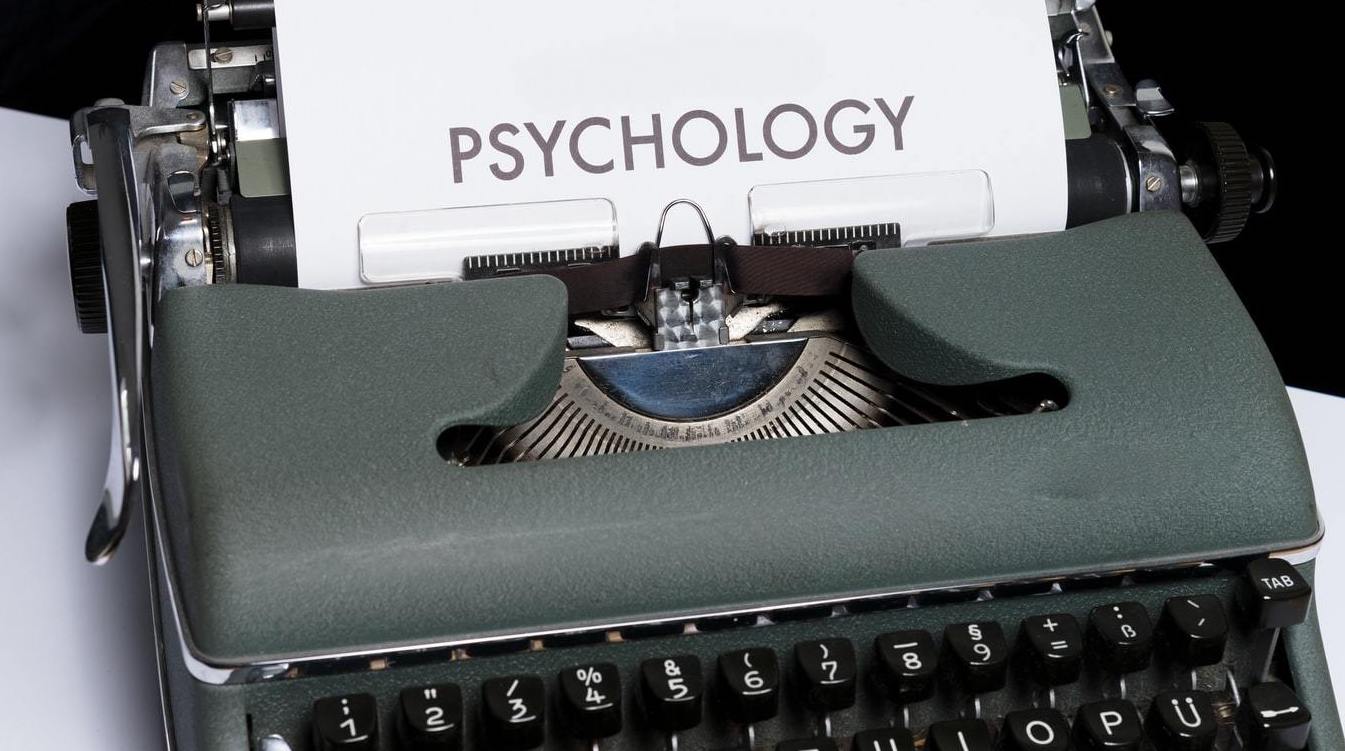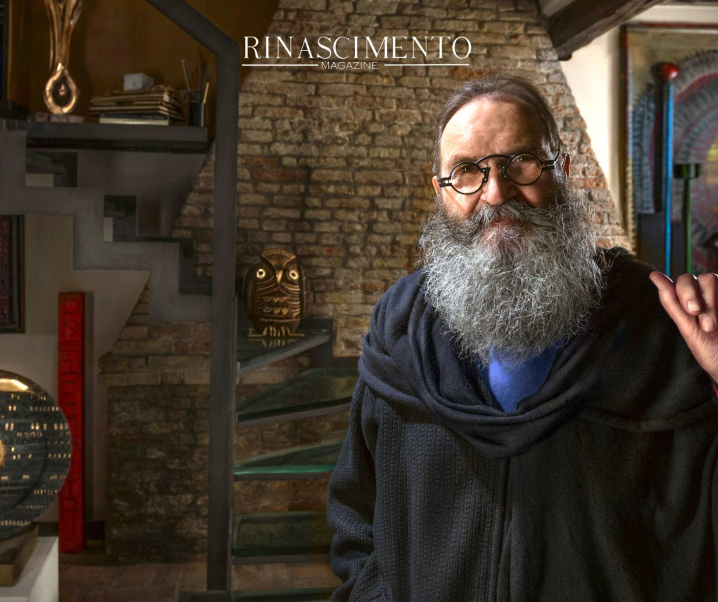Era il 2017 e quell’anno ho fatto una scoperta che avrebbe completamente cambiato la mia vita professionale. Stavo leggendo la recensione di un manuale di vendita appena stampato, quando ho incrociato una parola nuova, che ero certa di non aver mai sentito prima: la neurofinanza. Da studentessa di psicologia, ho capito subito che si parlava del cervello, ma sono rimasta sorpresa nel vederlo associato così chiaramente a una materia tanto diversa come la finanza.

Curiosa, ho indagato oltre e mi sono resa conto che se il libro ne parlava come strumento utile per essere commerciali più performanti, c’era anche una vera e propria branca della scienza che approfondiva come il funzionamento della mente incide sulle scelte economiche. Avevo finalmente trovato un solido ponte tra quanto stavo studiando all’università e il mio lavoro di consulente nel settore legale-bancario.

Cosa c’è di così entusiasmante nella neurofinanza? Allargandola un po’ di più, fino a includere la neuroeconomia o, come spesso viene anche chiamata, l’economia comportamentale, si comprende che è un tema molto interdisciplinare, che abbraccia l’economia stessa, la psicologia, la neurologia e diverse altre scienze. La cosa più interessante, però, è che spesso procede secondo schemi e teorie controintuitivi. Un tipico esempio è l’idea diffusa che le decisioni che si prendono sulla gestione del denaro siano sempre basate sulla razionalità e il buon senso. Parecchi esperti, invece, sono stati in grado di dimostrare il contrario, con esperimenti ideati apposta per questo tipo di ricerca.

Il primo ad applicare la psicotecnica, cioè l’utilizzo di nozioni psicologiche alle varie dimensioni della società e delle persone che la compongono, fu lo psicologo di origine tedesca Hugo Munsterberg (1863-1916). Fu sempre lui a introdurre l’espressione “psicologia industriale” e a dimostrare di apprezzare, nonostante le critiche che gli mosse, la visione dell’ingegnere americano Frederick Winslow Taylor (1856-1915) sul ruolo umano nelle dinamiche economico-aziendali. Il contributo di Munsterberg, quindi ha sbloccato l’orientamento settoriale della psicologia, portandola ad avere ruoli pratici non più solo incentrati sul risolvere problemi della mente umana o sulla comprensione soltanto scientifica del suo funzionamento.

I dati raccolti negli anni nei vari esperimenti e le conoscenze accumulate negli anni, permettono di creare dei pattern comportamentali che poi si ripercuotono nelle percezioni che le persone hanno quando devono svolgere compiti che implicano l’uso del denaro: come spenderlo, risparmiarlo e relazionarsi ad esso. E questo condiziona profondamente l’approccio che le principali figure del mondo economico hanno nel momento in cui devono rivolgersi al pubblico. Ecco che, le pubblicità, le presentazioni, gli oggetti e in generale il mercato usa dei metodi, più o meno tipici di un’epoca storica, che rispecchiano le caratteristiche della società, per attrarne l’attenzione e indurre delle azioni specifiche.

Potrebbe sembrare, allora, che l’economia comportamentale altro non sia che un insieme di strumenti mirati alla manipolazione. Come in tutte le cose, chi ne fa un utilizzo poco etico c’è, e prima o poi ne pagherà le conseguenze, soprattutto considerando che non è possibile convincere completamente e ciecamente qualcuno a fare ripetutamente cose che non sono in linea con i suoi valori e desideri. La neuroeconomia è piuttosto un mondo vivace, in cui il soggetto principale è l’uomo, come insieme di emozioni, esperienze, idee che ne plasmano l’attitudine in tutti i campi della vita.

Esplorarne la mente e capire che ad ogni determinata scelta e condotta nella quotidianità corrisponde a un perché, è un viaggio affascinante e pieno di colpi di scena.
A cura di Federica Wilson
Kredit Finder e Studiosa di Neuroeconomia